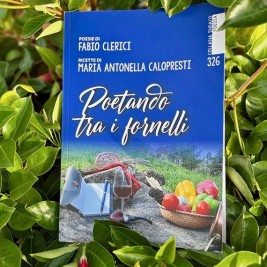- RISTORANTI-TRATTORIE
- Cremonese
- Cremasco
- Casalasco
- PIZZERIE
- Cremonese
- Cremasco
- Casalasco
- AGRITURISMI
- Cremonese
- Cremasco
- Casalasco
- PRODUTTORI
- Cremonese
- Cremasco
- Casalasco
- CONSORZI
- Cremonese
- Cremasco
- Casalasco
· Abbiamo qualcosa da raccontarvi: "Conoscere la storia dentro i nostri piatti " ·← Elenco BlogConoscere la storia dentro i nostri piatti
Che meraviglia muoversi tra le voci di “AtLiTeG”, “Atlante della lingua e dei testi della cultura gastronomica dall’età medievale all’Unità”: non c’è modo migliore per indagare la storia che sta dietro, e dentro, ai piatti delle nostre tavole. Ad esempio: nella scheda di una parola presa non proprio a caso, “torrone”, Chiara Murru ci spiega che «il vocabolo è in realtà probabilmente un ispanismo, da “turron”, a sua volta dal verbo “turrar” (“arrostire”)». È probabile, infatti, che il torrone si sia diffuso in Italia a partire da Napoli, zona di contatto tra la cultura italiana e spagnola. Nondimeno, la sua comparsa trionfale avviene nei ferraresi “Banchetti” di Cristoforo Messisbugo, risalenti alla metà esatta del Cinquecento (la cui recente edizione critica è stata curata da Veronica Ricotta). E la parola “mostarda”? Francesca Cupelloni scrive che, di fatto, si fronteggiano due ipotesi: un prestito dal francese antico, oppure una parola che arriverebbe dal longobardo. Nonostante non sia stagione, ci dobbiamo soffermare su “cotechino”: Francesca G. Mazzola spiega che «è un derivato nominale di cotica (…) con suffisso “-ino”; l’origine del piatto, probabilmente, è emiliano-romagnola». Vista l’estate, più che per il cotechino, molti opteranno per del prosciutto e melone. Come spiega Valentina Iosco, il nome “prosciutto” è derivato da un aggettivo, “asciutto”, con un cambio di prefisso. Se poi vi capiterà di fare una puntata in Liguria, sappiate che il nome “focaccia” – è sempre Iosco a dircelo – arriva “dal latino tardo Focācia(M), da Fŏcus (“focolare”) sul quale veniva cotta. Si potrebbe pensare che il primo testo in cui compare la parola sia conservato a Recco, Camogli o Genova: in realtà, il primo manoscritto in cui compare una variante del nome, “fugaçe”, è di area padovana, intorno alla metà del Duecento; così come “fugaza” compare a Venezia, nel 1499. Insomma: per trovare la ligurissima “fûgassa” bisogna aspettare il libro “La cuciniera genovese”, del 1893. Ma torniamo alla Pianura Padana: solo però per scoprire che, ci ricorda di nuovo Francesca Cupelloni, la parola “tortello” è attestata per la prima volta a Napoli all’inizio del Trecento e che il vocabolo conosce una certa fortuna documentaria, in seguito, tra la Campania e la Toscana. Solo nel 1549, sempre grazie a Messisbugo, arriva la prima testimonianza scritta della presenza dei tortelli sulle tavole padane.
Speriamo che questo antipasto – stuzzichini, rispetto alle portate che offre AtLiTeG – abbia solleticato l’appetito etimologico di chi cerca uno strumento filologicamente ineccepibile per condurre ricerche o rispondere a curiosità sulla storia gastronomica italiana. L’Atlante, consultabile gratuitamente online, è un progetto finanziato dal Miur ed è frutto del lavoro delle punte più avanzate della ricerca lessicografica italiana (l’attività di raccolta e definizione delle parole).
Fa piacere notare che al progetto hanno collaborato anche numerosi studiosi tra i 20 e i 30 anni, che – come ha constatato chi scrive – hanno affiancando al rigore scientifico un’autentica passione per la materia. A coordinare l’impresa è stata Giovanna Frosini, docente all’Università per Stranieri di Siena, ente capofila dell’iniziativa; le altre università coinvolte sono state la “Federico II” di Napoli, l’università di Cagliari e quella di Salerno.
Federico Pani
Categorie
Gli ultimi articoli
 Scopri
Scopri
le specialità dei ristoratori del territoriodai un'occhiataHai un ristorante?
Dare visibilità online al tuo locale è un buon modo per raggiungere nuovi clienti.
CONTATTACI© 2015 Andiamo a Tavola - Cremona | P. IVA 01287740193